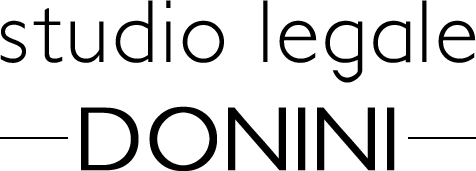La distinzione concettuale e funzionale tra atto pubblico e scrittura privata autenticata costituisce un cardine del sistema probatorio delineato dal codice civile, incidendo tanto sul piano sostanziale della validità ed efficacia degli atti quanto su quello processuale della loro utilizzabilità in giudizio.
L’atto pubblico, definito dall’art. 2699 c.c., è il documento redatto, nelle forme prescritte, da un pubblico ufficiale investito del potere di attribuirgli pubblica fede nel luogo di formazione. Tale nozione implica tre elementi costitutivi: la redazione ad opera del pubblico ufficiale rogante; l’osservanza delle formalità normative; l’effetto di pubblica fede. L’attività del pubblico ufficiale non è meramente ricettizia ma creativa: egli accerta l’identità, la capacità e la volontà delle parti, documenta i fatti avvenuti alla sua presenza e conferisce certezza giuridica all’atto.
Diversa è la scrittura privata autenticata, regolata dall’art. 2703 c.c.: qui il documento è predisposto dalle parti, mentre il pubblico ufficiale si limita ad attestare l’autenticità della sottoscrizione, previa verifica dell’identità del sottoscrittore. L’intervento pubblico ha dunque portata ridotta, essendo circoscritto alla genuinità della firma e non alla formazione del contenuto negoziale.
Le conseguenze sul piano probatorio sono di immediata evidenza. L’art. 2700 c.c. attribuisce all’atto pubblico efficacia privilegiata fino a querela di falso, sia in ordine alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale rogante, sia con riguardo alle dichiarazioni rese e ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza. Al contrario, l’art. 2702 c.c. riconosce alla scrittura privata (anche autenticata) piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della sottoscrizione, non estendendosi però alla verità intrinseca delle dichiarazioni, che resta liberamente contestabile con i mezzi ordinari di prova. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 12428/1993; Cass. civ., n. 679/1963) ha ribadito che la scrittura privata autenticata non ha l’efficacia probatoria dell’atto pubblico e che la contestazione del suo contenuto non richiede querela di falso.
Sul piano temporale, l’atto pubblico reca ex se data certa, mentre la scrittura privata, pur autenticata, resta soggetta alla disciplina dell’art. 2704 c.c., con possibili limiti di opponibilità ai terzi. In dottrina e giurisprudenza si è sottolineato il carattere “dualistico” della scrittura privata autenticata (Cass. pen., n. 9777/1994): essa contiene infatti un segmento privato (il negozio) ed un segmento pubblico (l’attestazione di autenticità), autonomi e non interferenti quanto a validità. Non a caso, Cass. civ., n. 10375/2000 ha escluso che l’autenticazione incida sulla validità sostanziale del negozio, operando esclusivamente sul piano probatorio.
L’art. 1350 c.c., che prescrive la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) per determinati contratti, pone sul medesimo piano le due forme quanto a validità. Tuttavia, la differenza emerge in sede di circolazione giuridica e opponibilità, come mostra la prassi notarile e la recente giurisprudenza di merito (Trib. Nocera Inf., n. 2844/2024), secondo cui la mera scrittura privata non autenticata non è idonea a produrre effetti traslativi immobiliari né ad essere trascritta.
Sul versante processuale, entrambe le forme possono costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., purché risultino documentati, con le stesse forme, anche i presupposti successivi all’insorgenza del credito (Cass. civ., ord. n. 52/2023). L’importanza della distinzione si riflette altresì in ambito amministrativo: talune procedure, come la costituzione di ATS, richiedono ad substantiam l’atto pubblico e non si accontentano della scrittura privata autenticata (TAR Puglia, n. 1696/2020).
In sintesi, la discrimen tra i due istituti risiede nell’estensione dell’attività certificatrice del pubblico ufficiale: ampia e penetrante nell’atto pubblico, circoscritta alla mera autenticità della sottoscrizione nella scrittura privata autenticata. Ne consegue che solo l’atto pubblico gode della piena pubblica fede ex art. 2700 c.c., mentre la scrittura privata autenticata ha funzione rafforzata rispetto a quella semplice, ma non gode di analogo privilegio. La scelta tra le due forme non è quindi meramente formale, bensì incide sulla sicurezza dei traffici giuridici e sulla tenuta probatoria degli atti in sede contenziosa.