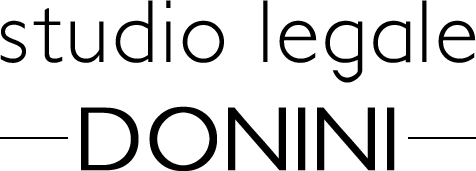Introduzione. Una questione che bruciava sotto la cenere
Da anni ci si interrogava su un punto concreto, ma spinoso: un proprietario può rinunciare in via unilaterale alla proprietà di un immobile, senza un destinatario e senza un trasferimento negoziale, limitandosi a dichiarare che non vuole più quel bene e a trascrivere l’atto nei registri immobiliari?
La risposta è arrivata in forma limpida con la decisione delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione dell’11 agosto 2025, n. 23093, Presidente D’Ascola, Relatore Scarpa.
La Corte ha affermato l’ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, precisandone la natura, gli effetti e i limiti, chiudendo un contrasto giurisprudenziale e disciplinando i profili più sensibili del controllo giudiziale.
Il pronunciamento trae origine da due rinvii pregiudiziali ex art. 363-bis c.p.c., emessi dal Tribunale di L’Aquila e dal Tribunale di Venezia, entrambi alle prese con rinunce formalizzate e trascritte su beni gravati da vincoli conformativi legati al rischio idrogeologico, in Abruzzo e in Veneto, e con la reazione dell’amministrazione statale che ne contestava validità e meritevolezza.
La Prima Presidente ha assegnato la questione alle Sezioni Unite, ritenendola di massima importanza nomofilattica, e il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta. La decisione, assai articolata, ha sciolto i nodi centrali e dettato principi di diritto destinati a fare da stella polare nelle aule di giustizia e negli studi professionali. Il testo integrale precisa, fra l’altro, i dati identificativi del provvedimento e la scansione procedimentale del rinvio pregiudiziale.
Il cuore della decisione. Che cos’è davvero la rinuncia abdicativa
La Corte colloca l’atto nell’orbita dei negozi unilaterali di disposizione patrimoniale: un atto non recettizio, che mira soltanto alla dismissione del diritto dominicale e non alla costituzione di un rapporto con altri soggetti.
L’atto si perfeziona con la dichiarazione del proprietario in forma scritta e con la trascrizione contro il rinunciante, mentre l’effetto di acquisto in favore dello Stato non nasce dal negozio ma dalla legge, come conseguenza automatica della vacanza del bene, ai sensi dell’art. 827 c.c.
L’ordinamento, insomma, non pretende un “secondo contraente” né un’accettazione pubblica: lo Stato acquista a titolo originario per effetto della situazione di fatto della res derelicta, e non perché destinatario di una traslazione convenzionale.
Ne deriva che la causa dell’atto si rinviene nella volontà dismissiva del titolare, espressione della facoltà di disposizione sancita dall’art. 832 c.c., e che la trascrizione, pur necessaria per l’opponibilità a terzi, non ha efficacia costitutiva né svolge la tipica funzione di risoluzione dei conflitti tra acquirenti prevista dall’art. 2644 c.c., poiché l’acquisto dello Stato è a titolo originario. La stessa decisione richiama espressamente questa architettura dogmatica.
I due principi di diritto. Un filo conduttore netto
Le Sezioni Unite hanno enunciato due principi. Il primo chiarisce che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale, non recettizio, il cui scopo tipico è soltanto dismettere il diritto come forma di esercizio della facoltà di disporre di cui all’art. 832 c.c., con l’acquisto dello Stato ex lege a titolo originario ai sensi dell’art. 827 c.c. L’atto trova causa in sé stesso e non nell’adesione di un altro soggetto.
Il secondo principio afferma che il cosiddetto fine egoistico del rinunciante non giustifica un sindacato demolitorio di nullità per violazione dell’art. 42, secondo comma, Cost., né per illiceità della causa o del motivo: le limitazioni collegate alla funzione sociale della proprietà, dice la Corte, spettano al legislatore, non al giudice, e dalla norma costituzionale non discende alcun dovere giuridico di essere o di restare proprietari. Viene escluso, inoltre, che l’atto si presti a configurare un abuso del diritto.
Queste proposizioni, riportate in modo testuale nel dispositivo, rappresentano la chiave interpretativa dell’intera pronuncia.
L’innesto costituzionale. Funzione sociale sì, ma con riserva di legge
Il dibattito aveva una vena di fondo: fino a che punto il principio della funzione sociale della proprietà, scolpito nell’art. 42, secondo comma, Cost., può imporre a un privato di trattenere su di sé un bene che non ha più utilità, solo per evitare l’impatto delle passività sul bilancio pubblico?
La Corte spiega che la funzione sociale opera attraverso la conformazione legale del contenuto del diritto, in forza di una riserva di legge che impedisce al giudice di convertire quel principio in una clausola generale di validità per sanzionare la rinuncia. Non si può derivare dall’art. 42 Cost. un dovere di permanenza nella proprietà per motivi di interesse generale.
L’eventuale esercizio antisociale del diritto – ammonisce il Collegio – resta pur sempre soggetto al controllo di responsabilità civile in presenza di comportamenti dannosi ai terzi; ma non si trasforma in un filtro demolitorio degli atti abdicativi legittimamente posti in essere. È un punto di equilibrio che respinge l’idea di una “proprietà forzata” come presidio surrettizio dell’interesse collettivo.
Il meccanismo legale dell’acquisto statale. Perché l’art. 827 c.c. torna centrale
La scelta del proprietario produce la vacanza del bene; la legge, non il rinunciante, fa decorrere l’acquisto pubblico.
L’art. 827 c.c. scolpisce una regola di chiusura del sistema: gli immobili che non sono di alcuno spettano allo Stato.
Ciò differenzia nettamente la vicenda da fattispecie traslative o da ipotesi in cui l’amministrazione deve accettare; qui l’amministrazione non diventa parte di un negozio traslativo né è chiamata a compiere atti di apprensione. Per i beni mobili l’ordinamento richiede l’occupazione, come segnala l’art. 923 c.c.; per gli immobili interviene la regola legale dell’attribuzione allo Stato. È dunque la vacanza a fungere da titolo dell’acquisto, non la rinuncia in quanto tale. Il passaggio è cruciale per comprendere perché non si possa piegare l’atto unilaterale a una sindacabilità che presupponga un “dialogo” contrattuale inesistente.
La forma, la trascrizione e l’opponibilità. Un cantiere tecnico che conta nella pratica
La Corte ribadisce che la rinuncia richiede la forma scritta ad substantiam e la trascrizione ex art. 2643, n. 5, c.c., da eseguirsi contro il rinunciante.
Non è pubblicità costitutiva, ma condizione di opponibilità. La sezione dedica specifici passaggi a chiarire che la trascrizione non svolge la funzione tipica di risolvere conflitti tra più aventi causa ex art. 2644 c.c., perché l’acquisto dello Stato, essendo a titolo originario, non si colloca nella catena derivativa.
Ne consegue che la cura redazionale dell’atto e la tempestività della trascrizione rimangono elementi pratici di rilievo per gli operatori, anche ai fini di una corretta tracciabilità nei registri e di una gestione ordinata dei rapporti con i terzi interessati.
La linea di confine con l’abbandono liberatorio e con le rinunce tacite
Nel diritto civile positivo esistono fattispecie in cui la rinuncia libera da obblighi propter rem o da oneri specifici, come accade in talune situazioni regolate dagli artt. 882, 963, 1104, 1070 c.c.
Quella è un’altra storia: lì la rinuncia concorre a risolvere assetti relazionali tra più soggetti, spesso all’interno di comunioni o di diritti parziari; qui invece si è di fronte a una dismissione pura del diritto di proprietà esclusiva, priva di funzione satisfattiva a favore di altri. La distinzione serve a evitare scorciatoie argomentative.
Allo stesso modo, la rinuncia abdicativa non coincide con comportamenti concludenti o con il mero abbandono materiale del bene: la Cassazione richiama da tempo la necessità della forma e della pubblicità, e la giurisprudenza anteriore già segnalava l’inammissibilità di rinunce implicite con effetti erga omnes.
La sentenza del 1996, n. 4945, è ricordata proprio su questo crinale, distinguendo la rinuncia agli effetti del possesso utile per usucapire dall’atto abdicativo sul diritto già maturato.
Il contesto processuale che ha portato alla pronuncia. Casi concreti, problemi reali
Le ordinanze di rinvio descrivevano terreni e fabbricati con vincoli di pericolosità idrogeologica, classificati nei piani di assetto territoriali. Il dato non è marginale: molte rinunce emergono proprio laddove il bene è divenuto privo di utilità economica o gravato da oneri di conservazione e messa in sicurezza che superano di gran lunga il valore.
Nelle memorie del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia del Demanio si dava conto di numerosi affari legali connessi al fenomeno, a riprova di una tendenza in aumento. Il giudice di merito aveva chiesto se fosse sostenibile una nullità virtuale o per causa illecita, o un abuso del diritto, o ancora una frode alla legge.
Le Sezioni Unite hanno risposto tracciando un confine netto, già richiamato, sulla base della riserva di legge in materia di limiti al godimento e alla disposizione proprietaria.
Il perimetro del sindacato giudiziale. Dove il giudice può intervenire
Non si esclude che l’atto sia sindacabile in termini diversi dalla nullità costituzionale invocata per la funzione sociale.
L’ordinamento conserva strumenti appropriati. Se l’atto pregiudica i creditori, questi possono esperire l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., poiché la rinuncia incide in peius sul patrimonio del debitore e modifica l’assetto delle garanzie. La Corte lo dice con chiarezza, ricordando che l’atto abdicativo rientra nella nozione di atto di disposizione, suscettibile quindi di essere reso inefficace nei confronti dei creditori ricorrendone i presupposti.
In parallelo, la responsabilità civile resta la sede per reagire a condotte dannose anteriori o connesse allo stato del bene. La funzione sociale non scompare, semplicemente non opera come chiave di nullità del negozio, ma come parametro di responsabilità e come spazio di intervento del legislatore.
Fine egoistico e meritevolezza. Un falso problema se non si scivola nel moralismo giuridico
L’idea che il proprietario rinunci per scaricare sulla collettività spese e rischi ha animato la polemica. Le Sezioni Unite smontano l’assunto, evitando sia il moralismo sia il formalismo.
Se l’ordinamento consente l’abdicazione e se l’acquisto pubblico discende dalla vacanza in forza dell’art. 827 c.c., non si può dire che l’atto persegua come causa la traslazione degli oneri sullo Stato. L’interesse del rinunciante è negativo, consiste nello sciogliersi dalla relazione di appartenenza; il resto è un effetto legale riflesso, non un esito posto come scopo dall’autore dell’atto.
Il controllo di meritevolezza ex art. 1322 c.c. non viene espanso sino a convertire la funzione sociale in clausola di invalidità, perché la riserva di legge chiude la via a interventi creativi del giudice.
A valle, restano vigenti gli strumenti generali sulla causa e sul motivo illecito, ma la mera convenienza economica del rinunciante non ne integra il presupposto.
La parabola del diritto vivente. Come si è arrivati qui
Nella motivazione le Sezioni Unite ricostruiscono i precedenti, spiegando che la giurisprudenza civile aveva già, in alcune pronunce, dato per implicita l’ammissibilità dell’atto abdicativo, purché nel rispetto dei requisiti formali.
Non è mancato il richiamo all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2020, in materia di occupazioni illegittime e di possibili assetti abdicativi in quel peculiare contesto: un ambito però confinato alla sequenza occupazione-rinuncia-esproprio anomalo, non estensibile per via analogica al tema generale della dismissione del diritto di proprietà immobiliare.
La decisione del 1997 n. 1907 delle Sezioni Unite, in tema di occupazione appropriativa, viene evocata come inciso storico che aveva lambito l’argomento; oggi la Corte colma quel vuoto di sistema.
Comunicazione al Demanio e pubblicità. La buona amministrazione come regola di condotta
Una domanda inevitabile riguarda i rapporti con l’Agenzia del Demanio.
La Corte chiarisce che un eventuale onere di comunicazione non incide sulla validità ed efficacia della rinuncia: si tratta, al più, di una regola di comportamento, rilevante sul piano della responsabilità qualora la mancata comunicazione favorisca situazioni di pericolo o ritardi nell’adozione di misure di sicurezza.
L’acquisto dello Stato, come detto, si produce ex lege e a titolo originario; non occorre accettazione. Le tesi che invocavano un potere statale di rifiuto con effetti ex tunc vengono esposte nelle memorie delle amministrazioni, ma non sono fatte proprie nel dispositivo.
È qui che la prassi professionale può introdurre protocolli di comunicazione tempestiva, senza confondere piani concettuali diversi.
Debiti, oneri pregressi e responsabilità. Che cosa non si spezza con l’abdicazione
L’atto di rinuncia non cancella ciò che è già sorto. Gli obblighi pecuniari maturati prima continuano a gravare sul rinunciante; lo stesso vale per responsabilità da fatto illecito derivanti da condotte o da stati pericolosi preesistenti.
La regola è coerente con l’impostazione generale: la proprietà si estingue, ma la responsabilità per eventi nati prima della dismissione non evapora.
Alla pubblica amministrazione non si trasmettono retroattivamente i debiti del privato; semmai lo Stato diviene titolare per il futuro, secondo i regimi normativi applicabili.
In caso di comunioni, servitù o oneri propter rem già innescati, la rinuncia non opera come strumento di liberazione retroattiva; l’eventuale liberazione discende, quando prevista, da specifiche norme settoriali, non dall’atto abdicativo in quanto tale. La motivazione delle Sezioni Unite insiste sul fatto che non si può utilizzare la categoria dell’impossibilità giuridica dell’oggetto per far saltare la rinuncia relativa a immobili “dannosi”, perché manca la base legale che vieti in assoluto il risultato perseguito dall’atto.
Da qui discende l’invito implicito alla due diligence pre-abdicazione, soprattutto nei contesti di rischio idrogeologico o di potenziale responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. o per cose in custodia ex art. 2051 c.c., senza dimenticare, nei casi estremi, i profili penali inerenti a disastri colposi.
La torsione verso gli strumenti di tutela creditoria. Revocatoria e oltre
L’esperienza pratica insegna che la rinuncia all’immobile può apparire, in talune circostanze, come una fuga dalle garanzie.
Il codice civile dispone però di un correttivo antico e sempre attuale. L’art. 2901 c.c. consente al creditore di chiedere che l’atto sia dichiarato inefficace nei suoi confronti, se posto in essere in pregiudizio delle sue ragioni e con la consapevolezza del debitore.
In questa cornice, il giudizio non verte sulla validità dell’atto in sé, ma sul suo regime di opponibilità: l’atto resta valido inter alios, ma non può essere opposto ai creditori vittoriosi. L’opzione interpretativa delle Sezioni Unite rimette al posto giusto i tasselli della tutela, evitando di caricare la funzione sociale di compiti che spettano agli strumenti tradizionali del diritto privato.
Una parola sulle teorie contrarie. L’argomento della “proprietà acefala”
Le tesi che negavano in radice la rinuncia evocavano lo spettro di beni senza titolare in attesa di essere acquisiti, con rischi per la sicurezza e per l’ordine pubblico.
La risposta della Corte è ordinata: la vacanza non è un buco nero, è un presupposto regolato dall’art. 827 c.c. che colma l’assenza di un proprietario mediante l’acquisto legale da parte dello Stato.
Non occorre una norma ad hoc per la rinuncia perché l’ordinamento già contiene la regola di sistema. Il bene non resta acefalo, e non si impone al singolo un ruolo di gestore forzato nell’interesse pubblico: quella funzione, quando occorra, viene assicurata dalle forme che la legge predispone, non da un’eterna permanenza coattiva nella proprietà privata.
Ricadute operative per proprietari e difensori. Come impostare il caso concreto
Nella pratica il professionista dovrà, per prima cosa, verificare requisiti formali e pubblicitari.
La forma scritta è imprescindibile; l’atto va predisposto con cura, indicando con esattezza il bene, gli estremi catastali, lo stato dei luoghi, e va portato in Conservatoria per la trascrizione contro il rinunciante.
In parallelo, si raccomanda, quale buona regola di amministrazione, una comunicazione tempestiva all’Agenzia del Demanio: non come condizione di validità, ma come condotta diligente, utile a evitare equivoci, ritardi o rischi ulteriori.
Sul tavolo della consulenza vanno poi messe le pendenze pregresse: imposte immobiliari maturate, oneri condominiali, eventuali obblighi di messa in sicurezza, situazioni di pericolo note o coltivate, contenziosi in corso. La rinuncia non fa da spugna; occorre, piuttosto, un bilancio delle responsabilità e una pianificazione degli adempimenti residui.
Sul fronte dei creditori, la discussione dovrà mettere in conto la possibile azione ex art. 2901 c.c., specie se la rinuncia incide sull’attivo aggredibile.
Tutto ciò senza sovrapporre la funzione sociale alla valutazione di validità del negozio, perché – lo ribadisce la pronuncia – il filtro di nullità spetta ad altre regole e al legislatore.
Un inciso sul diritto amministrativo e sull’esperienza della occupazione illegittima
La sentenza trae un confine tra il tema generale dell’abdicazione e i percorsi amministrativi legati alla c.d. occupazione usurpativa.
L’Adunanza Plenaria n. 2/2020 ha offerto coordinate in un ambito particolare, segnato da trasformazioni irreversibili del fondo in assenza di titolo, e da ipotesi di accordi transattivi o di acquisizioni legali speciali.
Quelle categorie non si possono traslare tali e quali nel terreno micro-sistemico dell’atto abdicativo puro, che non vuole trasferire, non intende compensare, non costruisce un rapporto con la pubblica amministrazione.
È una porta diversa, che si apre con una chiave diversa.
Le domande che resteranno sul campo. Legislazione futura e margini di riforma
La Corte, con una prudenza consapevole, non esclude che il legislatore, se lo riterrà opportuno, potrà rimodulare l’art. 827 c.c. o introdurre discipline settoriali per i beni vacanti, magari prevedendo forme di gestione, protocolli di presa in carico, priorità per la tutela della sicurezza e dell’ambiente.
È un passaggio importante, perché riconosce che la bilancia tra interessi collettivi e libertà dominicali può essere affinata per via normativa, senza alterare la solidità dei principi privatistici.
Il messaggio è chiaro: l’abdicazione resta, ma su di essa si possono innestare regole di governo del territorio e di prevenzione del rischio compatibili con la Costituzione.
Un promemoria di metodo per la difesa. Evitare la tentazione di piegare le categorie
Nella prassi contenziosa si è visto spesso tentare la strada della nullità per causa illecita, del motivo illecito determinante, della frode alla legge ex art. 1344 c.c., o persino dell’abuso del diritto in chiave demolitoria.
La sentenza ricorda che questi strumenti non possono trasformarsi in valvole di sfogo quando manca il relativo presupposto. L’art. 1322 c.c. si applica ai negozi atipici e consente un controllo di meritevolezza; ma l’atto abdicativo, qualificato e tipizzato quanto a funzione, non può essere costretto in un vaglio di “utilità sociale” confezionato caso per caso in assenza di base legale.
Laddove si intravedano condotte elusive, lo schema corretto transita per gli artt. 2901 c.c., 2043 c.c., 2051 c.c., 2053 c.c., e, nei profili estremi, per le norme penali. La dogmatica non si piega all’occasione.
Una chiosa sui fatti che hanno originato i rinvii. Terreni in area a rischio, utilità economica assente
È significativo che entrambe le vicende riguardassero beni collocati in zone sottoposte a vincoli di pericolosità idrogeologica, con evidenti limiti alle facoltà di godimento e di trasformazione.
Proprio lì la proprietà rischia di perdere il suo valore d’uso, e il costo della gestione supera i benefici immaginabili. Il fenomeno, come evidenziato nelle memorie delle amministrazioni, risulta diffuso in diversi contesti regionali.
La pronuncia prende atto del dato, ma non lo trasforma in criterio di validità del negozio: semmai lo affida agli strumenti della responsabilità e alla possibile futura elaborazione legislativa.
Che cosa cambia, in concreto, per chi assiste i proprietari
Un avvocato che riceve l’incarico dovrà costruire un percorso in tre passaggi.
Primo: inquadramento del bene e dei suoi carichi, con un’analisi documentale completa, per evitare che l’abdicazione sia usata in modo improprio o produca effetti indesiderati verso terzi.
Secondo: predisposizione dell’atto in forma rigorosa, con tutti gli elementi identificativi, e deposito per la trascrizione; a margine, comunicazione all’Agenzia del Demanio come condotta diligente.
Terzo: gestione del dopo, perché eventuali obblighi già sorti non evaporano; occorre perimetrare responsabilità pregresse, verificare lo stato di conservazione e adottare, se del caso, misure idonee a rimuovere pericoli già imputabili al proprietario uscente.
Se sono pendenti crediti, è prudente anticipare la possibile reazione in revocatoria, impostando una difesa fondata su presupposti oggettivi e non sull’idea della rinuncia come scudo magico. La decisione delle Sezioni Unite non lascia alibi, ma offre certezze su cui lavorare.
E per le amministrazioni pubbliche?
L’effetto legale di acquisto al patrimonio disponibile dello Stato non può essere rifiutato per via interpretativa.
Ciò non toglie che l’ente possa e debba attivare i propri poteri per la sicurezza dei luoghi e per la tutela del territorio, anche avvalendosi delle norme in materia di protezione civile, edilizia e ambiente, oltre che dei rimedi civilistici per il risarcimento dei danni causati da condotte pregresse.
Nel frattempo, la buona cooperazione istituzionale può essere favorita da linee guida operative sulla presa in carico dei beni vacanti, soprattutto quando insistano in contesti di rischio. La pronuncia non depotenzia l’interesse generale; lo riconduce, semplicemente, ai canali corretti.
Conclusioni. Una bussola per il contenzioso e per la consulenza
La sentenza n. 23093/2025 fornisce una bussola semplice: la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è possibile; è un atto unilaterale non recettizio, che richiede la forma scritta e la trascrizione contro il rinunciante; produce l’acquisto dello Stato ex art. 827 c.c. per effetto della vacanza; non può essere colpita da nullità per il solo fine egoistico, perché le limitazioni imposte dalla funzione sociale della proprietà spettano al legislatore; resta ferma la responsabilità per le condotte pregresse e la tutela dei creditori mediante revocatoria.
Le categorie civilistiche vengono preservate, senza cedere alla tentazione di far dire all’art. 42 Cost. ciò che non dice.
Sul piano operativo, la consulenza legale guadagna in certezza: l’atto abdicativo non è un espediente, ma uno strumento riconosciuto, da usare con prudenza, consapevoli che ciò che è già accaduto non si cancella e che l’interesse pubblico ha altre porte d’accesso.
Le Sezioni Unite non hanno creato un diritto nuovo; hanno rimesso ordine, ribadendo che esiste uno spazio di libertà nella disposizione del bene e che, accanto ad esso, scorrono, senza confondersi, le correnti della responsabilità e della tutela collettiva.
*Coautore: dott. Francesco Romeo